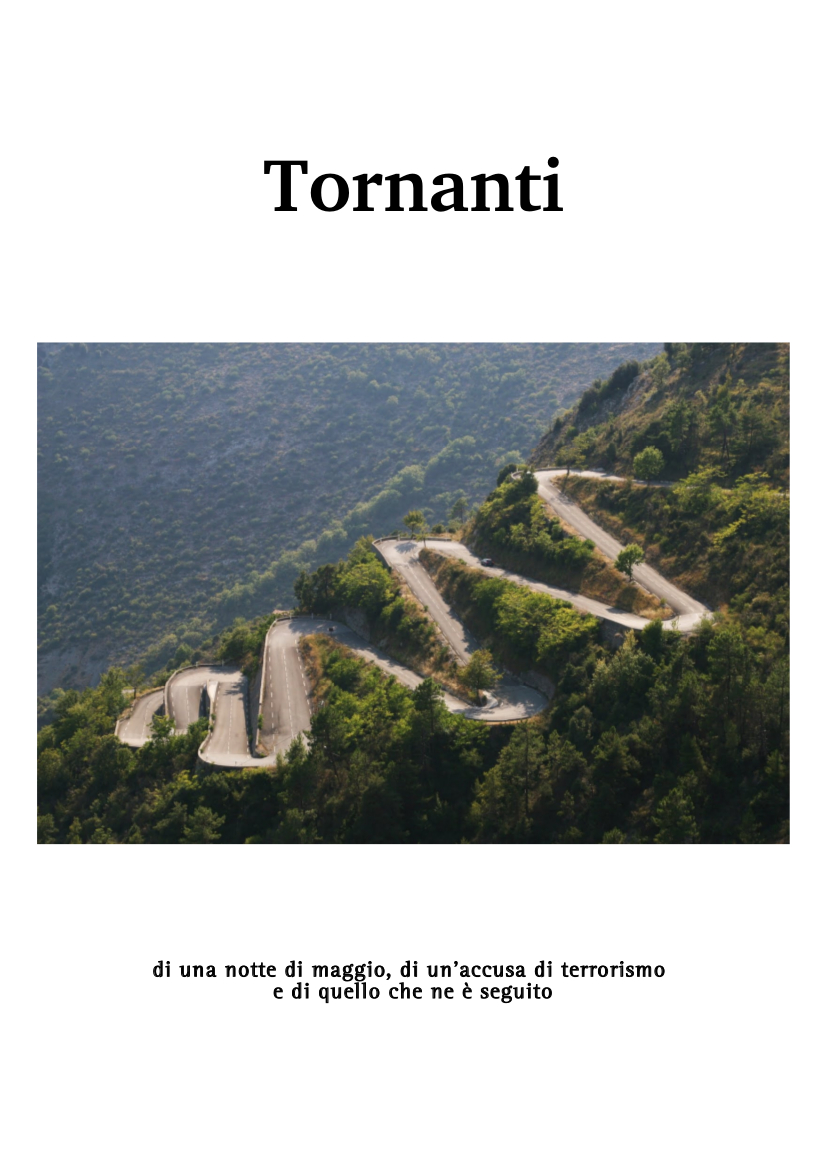
Tornanti
Pubblichiamo un testo lungo e corposo.
Sebbene sia stato scritto da alcuni redattori di //Macerie e storie di Torino// non è tuttavia un testo redazionale: è stato elaborato tenendo conto di molte osservazioni, affrontando discussioni con altri compagni torinesi, accogliendo alcune critiche e respingendone altre.
Speriamo che possa essere discusso ancora e altrove, perché i problemi che pone, molti più numerosi di quelli a cui vuol rispondere, ci sembrano ambiziosi e urgenti. E non solo per la lotta contro il Tav.
Qui potete trovare una versione in pdf del testo.
Cliccando qui trovate invece una versione impaginata e pronta per essere stampata.
I bilanci si fanno alla fine.
Ciò che segue non è quindi un bilancio, ma sono solo delle riflessioni in ordine sparso a partire dalla solidarietà sviluppatasi attorno agli arrestati per il sabotaggio al cantiere di Chiomonte del maggio 2013.
Non ci sembra infatti sia possibile provare a tirare le somme. Non solo perché non è ancora terminata la vicenda processuale dei sette compagni arrestati, ma soprattutto perché a continuare è la lotta contro la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.
E gran parte delle iniziative e dei discorsi successivi a questi arresti hanno tentato di tenere costantemente intrecciate la difesa dei compagni in carcere e l’opposizione al Tav, nella convinzione che la migliore risposta alla repressione sia quella di non consentirle di stroncare il percorso di lotta contro cui è indirizzata l’azione dei magistrati.
A dir la loro su questi arresti, a dar vita e partecipare alle diverse iniziative di solidarietà sono stati moltissimi uomini e donne. Un evento straordinario, in senso letterale. Extraordinario perché è difficile ricordare una solidarietà con un’intensità e un’ampiezza tali. Ma letterale anche perché non si tratta di caricare questo termine con un’aura talmente positiva da porlo al di sopra di ogni critica.
L’auspicio è che queste righe possano contribuire a sottolineare ciò che si è fatto di buono ma anche le potenzialità inespresse e i limiti emersi, così da poter essere d’aiuto quando altre inchieste ed altri arresti tenteranno di ostacolare l’opposizione al Tav, o tutte le altre lotte.
Per quanto scontato, è comunque meglio ribadire che questo è un testo di alcuni compagni di Torino che hanno contribuito attivamente alla solidarietà nei confronti degli arrestati.
Un testo che quindi esprime riflessioni, tensioni e prospettive parziali, le nostre.
Prima di provare a ragionare più approfonditamente su come e quanto si sia riuscita a manifestare la propria solidarietà nei confronti dei compagni arrestati, e a rilanciare l’opposizione all’Alta Velocità, è il caso di partire da uno degli elementi che ha dato così tanto rilievo a questa inchiesta giudiziaria: l’accusa di terrorismo.
Nel tentativo di colmare una lacuna: l’articolo 270-sexies c.p.
L’articolo su cui la Procura di Torino ha tentato di poggiare la sua accusa di terrorismo contro i responsabili del sabotaggio al cantiere di Chiomonte del maggio 2013 è l’ormai sufficientemente noto 270-sexies. E più precisamente la parte di quell’articolo che definisce come terroristica la condotta volta a costringere le istituzioni a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto. Molto è stato scritto e detto su questo punto: se i reati di terrorismo vengono definiti reati d’autore in quanto dipendono dall’identità di chi li commette più che dal gesto illegale in sé, la possibilità di poter etichettare come terrorista chiunque decida di mettere i bastoni tra le ruote ad un singolo progetto democraticamente approvato rappresenta per lo Stato un ottimo strumento per contrastare chi turba la pace sociale.
È notevole il fatto che per ricevere una etichetta simile, e gli anni di carcere che essa garantisce, ieri si dovesse essere accusati di «voler sovvertire le istituzioni democratiche», di voler far la Rivoluzione insomma, oggi invece basta, tra le altre cose, opporsi realmente alla costruzione di una ferrovia; è notevole perché sembra dirla lunga su quanto l’asticella di ciò che lo Stato è disposto a tollerare si stia notevolmente abbassando.
Ma in fondo non è questo l’aspetto più significativo del 270-sexies.
Cerchiamo di vedere cosa la legislatura in materia di terrorismo ha da dirci riguardo al mondo in cui viviamo, e in particolare riguardo alle lotte che tentano in qualche modo di scompaginarlo. Gli articoli di legge in materia di terrorismo, in uso dal 1980 e precedenti alla concezione del 270-sexies, erano pensati per far fronte a movimenti di lotta caratterizzati da un forte collante ideologico, che quindi dichiaravano esplicitamente il proprio carattere rivoluzionario. Era questo il nemico contro cui lo Stato, allora, avvertiva la necessità di dotarsi di tali strumenti repressivi.
Oggi, il nemico che il 270-sexies chiama in causa sembra invece molto diverso; diversi sembrano infatti i conflitti che caratterizzano, con ampiezza e radicalità relative, il periodo attuale.
Un rapporto del Censis di qualche anno fa sottolineava come «il malessere rimane allo stato fluido fino a che non avviene qualcosa che ne consente il coagulo intorno a fatti di elevata specificità. Fatti che possono essere molto diversi tra loro, ma che fungono da inneschi. Può essere una crisi aziendale, un progetto di trasformazione territoriale, una proposta di legge, addirittura un fatto di cronaca o una semplice dichiarazione di intenti proveniente dalla sfera pubblica».
Ci si organizza e si lotta prevalentemente per contrastare singoli progetti dello Stato – una nuova ferrovia o trivellazioni petrolifere – o per far fronte a problemi circoscritti (ancorché collettivi) – come la casa, le bollette o dei licenziamenti. Non viene messa in discussione, esplicitamente o in toto, l’esistenza dello Stato, del Capitale, della Borghesia o del Potere, a seconda delle preferenze e inclinazioni di ognuno. E tutto lascia prevedere che anche in futuro continueranno ad essere questi i tipi di movimenti e di lotte che perlopiù alimenteranno la conflittualità sociale.
Il 270-sexies è dunque servito a colmare questo vuoto legislativo.
L’inchiesta per i fatti di Chiomonte è il primo tentativo in grande stile di testarne funzionamento ed efficacia.
Non si può non riconoscere che, ancor più che in passato, in quest’occasione lo Stato ha mostrato una notevole lungimiranza, dotandosi per tempo di una serie di strumenti che potranno tornargli utili per affrontare le minacce future.
Dato a Cesare ciò che è di Cesare, è bene però sottolineare come questo primo test si sia dimostrato, per le autorità, un fallimento. Non stiamo parlando dell’aspetto strettamente processuale, dato che l’iter deve ancora concludersi. Né il campo giudiziario può costituire il terreno su cui chi lotta deve muoversi o misurare la bontà di ciò che ha fatto.
Boomerang
Chi lotta contro il Tav non si è fatto spaventare dalla portata delle accuse.
Il movimento si è anzi compattato, stringendosi attorno a chi era rinchiuso in carcere, rendendo questi arresti un’occasione per rilanciare una resistenza che non attraversava certo uno dei suoi momenti migliori. Sin da subito c’è stata una chiara consapevolezza di come la posta in gioco andasse ben oltre i confini della Valsusa e dell’opposizione al Tav. Una consapevolezza condivisa anche con altre esperienze di lotta che potrebbero essere attaccate, presto o tardi, a colpi di 270-sexies; numerosi e diversissimi sono stati i messaggi di solidarietà arrivati dai più svariati contesti ai compagni in carcere, e tanti i dibattiti e le iniziative organizzati un po’ ovunque.
Tra queste da sottolineare in particolar modo la giornata del 22 febbraio 2014, quando in più di 40 città e paesi, moltissimi uomini e donne hanno manifestato la propria solidarietà agli arrestati a partire dalle ragioni del proprio No; o quella del 10 maggio dello stesso anno, quando diverse migliaia di persone, tra cui molte non appartenenti ai tradizionali circuiti militanti, hanno attraversato in corteo il centro di Torino a pochi giorni dall’inizio del processo.
Oltre a riconoscere la posta in gioco si è anche rispedita al mittente l’accusa di terrorismo.
Non ci sono stati – cosa non da poco, specie in un movimento di solidarietà così ampio – pubblici distinguo con cui spesso, nel difendere qualcuno dall’accusa di essere un terrorista, si rimarcano prontamente le distanze tra l’accusato e qualcun altro, così da lasciar intendere in maniera più o meno esplicita che a quest’ultimo l’etichetta di terrorista non starebbe poi male.
L’accusa di terrorismo è stata rispedita al mittente dato che si è sempre affermato che terrorista è chi «devasta e militarizza i territori», una perifrasi che indica evidentemente lo Stato. Una delle poche eccezioni a riguardo è stata rappresentata da un opuscolo, intitolato Welcome to the Terrordome, distribuito durante il corteo del 10 maggio 2014. Sebbene epurato in seguito delle parti più impresentabili, la questione è stata affrontata dai suoi autori in maniera contraddittoria e confusa, riproponendo proprio quelle immagini, quei concetti e quei ragionamenti tipici dei mass-media, che l’opuscolo intendeva esplicitamente «smontare».
Nel suo complesso, la reazione a questi arresti è stata quindi un’ottima dimostrazione di come far sì che un’inchiesta possa tramutarsi in un boomerang per chi l’ha pianificata. Un boomerang reso ancor più affilato dal fatto che sin da subito, nel difendere gli arrestati, si sia difesa senza se e senza ma anche l’azione di cui questi erano accusati: il danneggiamento tramite lancio di bottiglie molotov di alcuni mezzi del cantiere di Chiomonte. Una solidarietà indipendente quindi dalla loro innocenza o colpevolezza. O meglio, ripensando al calore e all’entusiasmo suscitati dalle dichiarazioni con cui in tribunale alcuni imputati hanno detto di aver partecipato a quel sabotaggio, una solidarietà all’insegna del: «siamo al vostro fianco se siete innocenti… e ancor più se siete colpevoli».
Una breve parentesi
Subito dopo l’azione del 13 maggio, il Movimento No Tav, attraverso alcuni suoi esponenti difende pubblicamente questo sabotaggio, dichiarando che quando, come nel caso della lotta No Tav, le si è provate un po’ tutte e non vengono lasciate altre possibilità, il sabotaggio diventa un mezzo necessario per continuare a resistere. Citando poi alcuni passi di Capitini e Mandela si descrive il sabotaggio, quando diretto a danneggiare cose e non persone, come una pratica che può a pieno titolo essere utilizzata da chi si considera non-violento.
Prima di affrontare la questione «sabotaggio», ci sembra però opportuno partire da un problema di cui si discute poco e trascurato finora dai più, compreso chi scrive.
Il problema del «chi parla per chi».
Come altri movimenti di lotta, anche il Movimento No Tav non ha mai scelto formalmente, al suo interno, dei delegati o portavoce autorizzati a parlare a nome dell’intero Movimento. Nel corso del tempo, diversi uomini e donne hanno ricoperto questo ruolo, per periodi più o meno lunghi, in virtù di alcune caratteristiche riconosciute loro – come ad esempio la costanza nella lotta, il carisma, la capacità oratoria e l’intuito.
È accaduto più volte, si pensi ad esempio ad alcune conferenze stampa ma non solo, che le valutazioni di questi portavoce non fossero frutto di precedenti discussioni collettive svoltesi negli spazi organizzativi che il Movimento si è dato, come le assemblee popolari o i coordinamenti dei comitati. E non è semplice comprendere quando e quanto queste valutazioni individuali rispecchiassero il sentire degli altri No Tav che compongono il Movimento. E se anche fosse possibile riportare un sentire comune, non è affatto facile capire quanto ciò sia dovuto al «fiuto» di chi ha parlato, cioè alla sua capacità di comprenderlo e farsene portavoce, o quanto invece non siano state piuttosto le parole di questi portavoce a influenzare poi il sentire generale.
La difesa del caso di sabotaggio da cui eravamo partiti è stata articolata durante un’assemblea in Valsusa, riproposta dopo i sabotaggi che nelle settimane successive hanno colpito alcune ditte che lavorano nel cantiere di Chiomonte, e ripresa e sostenuta con diverse manifestazioni e iniziative dopo gli arresti – ripetendo «quella notte c’eravamo tutti»; questo fatto consente di affermare, perlomeno secondo chi scrive, che questa difesa a spada tratta esprimesse il pensiero di tanti No Tav, per quanto sia probabile che qualcuno fosse parzialmente o totalmente in disaccordo ma non abbia voluto esprimerlo apertamente.
Se prendiamo invece in considerazione un caso in cui degli atti di sabotaggio contro delle ditte che lavoravano nel cantiere sono stati etichettati come delle provocazioni, come nell’estate del 2011, subito dopo lo sgombero della Maddalena, è difficile dire di quale consenso godesse questa presa di posizione, per quanto non sia stata molto criticata. Una difficoltà legata al fatto che su questi sabotaggi non ci fu un confronto assembleare precedente a questa presa di distanza. E criticarla pubblicamente in seguito, come è accaduto solo su qualche giornale o sito internet di movimento, non era certo facile, per il timore di esporsi.
Sarebbe quindi della massima importanza che se (la cui cosa non è pacifica né scontata) un movimento sceglie di avere dei portavoce – perché di scelta si tratta – chi parla e cosa vien detto a nome di tutti sia deciso attraverso criteri precisi e rigorosi. Altrimenti il rischio è che si radichino, a tal punto da divenire normali, una serie di atteggiamenti e modi di fare che ostacolano il confronto e le discussioni, immiserendo così il dibattito e la lotta nel suo complesso. Un problema che non è reso meno grave dal fatto che spesso molti accettano di buon grado la possibilità di delegare a qualcun altro tutta una serie di impegni e responsabilità.
Il passaggio del «chi parla per chi» è solo un aspetto del più generale problema di quanto le strutture organizzative e le modalità decisionali di cui un movimento si dota favoriscano o piuttosto soffochino l’autorganizzazione della lotta. Una questione che nel caso del Movimento No Tav è resa ancor più complicata dal fatto che non esiste un criterio preciso per stabilire chi faccia parte e chi no di questo Movimento, e qui indichiamo con questa grafia il movimento che si oppone alla costruzione della Torino-Lione, visto che chi si oppone ad altri corridoi dell’Alta Velocità aggiunge delle specifiche al proprio nome (come ad esempio No Tav Terzo Valico). In questo caso non ci sono tessere, e sono state tantissime le persone che hanno partecipato attivamente e con costanza alla lotta in Valsusa senza far parte di alcun comitato, senza vivere in Valle e neanche nella cintura di Torino.
Sabotaggio: non violenza vs violenza?
Come detto, nella difesa del sabotaggio pronunciata in Valsusa nel maggio 2013, si è descritta questa come una pratica che può appartenere a pieno titolo a una lotta non-violenta.
Una presa di posizione importante che sarebbe più che auspicabile fosse fatta propria un po’ da tutti i partigiani della non-violenza. Così che le azioni non-violente abbandonino la logica della testimonianza su cui ci sembra si siano adagiate, e cerchino un modo per contribuire in maniera più concreta alle lotte. La sensazione di chi scrive, che non è un non-violento, è infatti che in tante occasioni non-violenza faccia rima con rispetto della legalità, così che si sceglie cosa fare e cosa non fare non in base a ciò che si ritiene più giusto e nel contempo utile alla lotta, ma con il codice penale in mano, rendendo così lo Stato il depositario dei criteri etici a cui chi lotta dovrebbe attenersi. Un abisso da quanto fatto e detto nella sua storia dal Movimento No Tav.
Nell’includere il sabotaggio tra gli strumenti della lotta non-violenta, si è messo l’accento sulle proprie convinzioni: danneggiare o distruggere dei macchinari risulta un prezioso bagaglio nell’opposizione reale ad un progetto imposto da altri.
Fatto ancora più notevole è che a una tale posizione non si sono aggiunti espliciti giudizi contro eventuali azioni di sabotaggio, e contro i loro autori, che potrebbero coinvolgere delle persone.
Ragionare sul rapporto tra violenza, non-violenza e lotte non è certo semplice e non a caso questo dibattito attraversa l’intera storia dei movimenti di lotta, anche quelli rivoluzionari. Le diverse posizioni a riguardo sono caratterizzate da sentimenti e valutazioni di varia natura e risultano pertanto ricche al proprio interno di differenze e sfumature. A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato poi il revisionismo subìto dalle lotte degli anni ’60 e ’70 che ha reso la violenza un argomento tabù nell’ambito dei conflitti sociali.
Alla luce di queste difficoltà sarebbe veramente prezioso provare a ragionarne in maniera seria e approfondita all’interno di una lotta di questo tipo. Una discussione simile, all’interno del Movimento No Tav, potrebbe risultare particolarmente viva e interessante. Perché molti potrebbero parteciparvi partendo dal proprio vissuto, da come l’esperienza maturata nel corso della lotta contro il treno veloce abbia influenzato – modificando, rafforzando o semplicemente rendendo più chiare le idee che si avevano a riguardo – il loro rapporto con la violenza. Per provare a discuterne adeguatamente crediamo sia quindi necessario non adagiarsi su definizioni o ragionamenti che tendono a semplificare o eludere alcuni problemi, piuttosto farli emergere percorrendo tutte le strade possibili.
Nella sua difesa del sabotaggio, il Movimento No Tav ha definito la lotta contro la linea Torino-Lione una lotta non-violenta. Una definizione che non ci sembra molto precisa. Pensiamo ad esempio al 3 luglio, quando un gran numero di uomini e donne, nel tentativo di rioccupare l’area in cui si era appena insediato il cantiere, non si sono tirati indietro di fronte alla necessità di scontrarsi con le forze dell’ordine. E nei giorni successivi, in cui al martellamento mediatico volto a spingere il Movimento, o almeno una parte di esso, a prendere le distanze e condannare le violenze, la risposta pubblica è stata «Siamo tutti black-bloc».
Premettiamo di non essere degli esperti in materia, ma abbiamo sempre pensato che chi agisce guidato dall’etica o dall’ideologia non-violenta, dovrebbe evitare di rischiare che ciò che fa possa far male o ferire qualcuno, anche se in reazione a una violenza subita, anche se lo fa perché attaccato per primo, per difesa. Si dovrebbe quindi, in determinate condizioni, rinunciare a determinate iniziative per evitare di correre il rischio di far violenza contro qualcuno, dato che è facile immaginare che tali iniziative possano innescare una spirale di violenza; oppure si dovrebbe essere disposti a subire senza reagire attivamente, ad esempio tenendo le mani alzate davanti a un reparto di celerini che carica.
Se invece riteniamo di poter usare violenza contro qualcuno, se costretti a farlo per difenderci, perché stiamo subendo una violenza da cui vogliamo liberarci, o perché anche a causa di questa violenza ci stanno imponendo delle decisioni che contestiamo, allora è difficile definirsi non-violenti, fare della non-violenza il criterio primo e più alto su cui basare il proprio agire.
L’8 dicembre 2011, prima che iniziasse un assedio al cantiere, un No Tav, in un discorso al megafono che incitava a circondarlo, indicò le recinzioni e i macchinari all’interno dello stesso come l’obiettivo da danneggiare, specificando che non lo erano invece le forze dell’ordine che lo difendevano. «Sì, ma data la legge fisica che impedisce a un corpo di attraversarne un altro, cosa facciamo se tra noi e quelle recinzioni e macchinari incontriamo degli uomini in divisa?» fu la domanda un po’ retorica con cui qualcuno rispose all’intervento al megafono.
E sono numerose le giornate che mostrano come in molti tra coloro che lottano contro il treno veloce siano consapevoli della non-attraversabilità dei corpi, e altrettanto determinati a trovare un qualche modo per ovviare a questa legge della fisica.
A chi scrive sembra proprio che il rapporto con la violenza all’interno della lotta No Tav sia regolato da criteri di questo tipo. Non si esclude a priori la possibilità di farvi ricorso, diversamente da quanto dovrebbe accadere in una lotta non-violenta, ma si accetta questa possibilità come un fatto sgradito, che si preferirebbe evitare, ma che purtroppo è alle volte necessario, perché sono le ragioni della lotta a imporlo.
Le valutazioni su cosa imponga la lotta, per non essere costretti a tornarsene a casa o limitarsi a iniziative di testimonianza, non sono certo oggettive. Come non sono oggettivi i criteri che consentono di stabilire dove cominci e soprattutto dove termini il carattere difensivo di un nostro comportamento. Scriveva a proposito un rivoluzionario vissuto agli inizi del secolo scorso: «La violenza è giustificabile solo quando è necessaria per difendere se stesso e gli altri contro la violenza. Dove cessa la necessità comincia il delitto. Ma lo schiavo è sempre in stato di legittima difesa e quindi la sua violenza contro il padrone, contro l’oppressore, è sempre moralmente giustificabile e deve essere regolata solo dal criterio dell’utilità e dell’economia dello sforzo umano e delle sofferenze umane».
Una volta messa in discussione la definizione di lotta non-violenta ci si trova dunque a dover affrontare criticamente una serie di problemi messi finora sotto il tappeto. Problemi vissuti magari in prima persona, ma su cui non si è stati finora obbligati a ragionare e discutere insieme ad altri – attività che richiedono un’attenzione e una precisione ben maggiori di quelle utilizzate quando si riflette tra sé e sé. Uno sforzo collettivo che abbiamo già detto sarebbe invece auspicabile, specie se non ricercasse una sintesi o un’identità di vedute ma tendesse piuttosto a favorire la possibilità che ognuno si esprima a riguardo, così da far emergere i diversi perché e le tante sfumature di cui queste convinzioni sono ricche. In modo da poter valutare più adeguatamente se e come valutazioni differenti possano convivere. Se e come tutti coloro che ritengono la non-violenza un criterio irrinunciabile dell’agire possano camminare al fianco di chi ha una visione diversa del rapporto tra lotte e violenza, e viceversa.
Un dibattito ben lontano insomma da come vengono affrontate abitualmente questioni simili in diversi ambiti e lotte, da diversi militanti, quando a prevalere difficilmente sono contenuti e disponibilità al confronto, ma piuttosto scomuniche ed insulti.
Sabotaggio: tra pratica e metodo
La difesa del sabotaggio del maggio 2013 è successiva ad una serie di affermazioni per cui, negli anni precedenti, delle azioni di sabotaggio contro alcune ditte coinvolte nella realizzazione della Torino-Lione erano state invece bollate come provocazioni o atti compiuti per incassare i risarcimenti delle assicurazioni.
Un cambiamento non da poco.
Proviamo a spendere qualche parola su una certa cultura del sospetto che giudica un certo tipo di azioni, specie se realizzate al chiaror di luna, sempre un po’ oscure. Dietro di esse si nasconderebbero particolari interessi, che nel migliore dei casi niente hanno a che vedere con la lotta, nel peggiore vogliono invece apertamente danneggiarla.
Se questa propensione a ricercare trame oscure e complotti accomuna molti, non tutti sostengono queste tesi per gli stessi motivi. In alcuni casi lo si fa in buona fede perché la dietrologia è un modo molto comune di interpretare certi eventi.
In altri, invece, la buona fede non conta, e anche se non si è realmente convinti delle tesi complottiste le si sostiene per scongiurare la possibilità che certe pratiche e certi metodi si diffondano.
Nel primo caso, oltre alle critiche puntuali da porre ogni qualvolta viene stravolto il senso di alcune azioni, il miglior antidoto contro la dietrologia saranno le lotte stesse, con la loro capacità di modificare lo sguardo con cui si è abituati a vedere il mondo. Nel secondo invece non esistono antidoti: il sostegno o meno alle teorie complottiste non è tanto legato ad un propria visione del mondo quanto alla direzione verso cui si vorrebbe far soffiare il vento.
Ma al di là del problema della dietrologia e di ciò cui abbiamo accennato sopra, di quanto simili letture dietrologiche siano realmente condivise all’interno del Movimento, non crediamo sia particolarmente strano che durante una lotta possano verificarsi cambiamenti di valutazione tali, per cui una stessa pratica venga prima denigrata e poi difesa.
È comprensibile che chi lotta contro un determinato progetto – quando è realmente disposto a ragionare su cosa sia necessario fare di volta in volta per dare concretezza al proprio No, come ci sembra sia il caso del Movimento No Tav – decida sul da farsi a partire dalle necessità che di volta in volta reputa stia imponendo la lotta, e in base all’esperienza nel frattempo accumulata nel corso di essa.
E questo è uno dei motivi per cui le varie pratiche utilizzate nel corso delle lotte, per quanto siano di per sé sempre giuste – è sempre giusto bloccare una strada per impedire il passaggio di ruspe e mezzi da cantiere pronti a bucare una montagna, o incendiarli quando sono ancora parcheggiati nella propria sede o in un cantiere – non risultano sempre ugualmente significative all’interno di una lotta.
Alle volte un sabotaggio riesce a indicare un modo efficace per opporsi a un determinato progetto; e nel farlo, oltre ad aiutare a tenere alti gli umori e infondere coraggio, può divenire una proposta su ciò che si può fare valida per tanti. Altre volte, perché troppo in anticipo rispetto allo sviluppo della lotta, perché poco comprensibile o perché ha adottato delle modalità o scelto un obiettivo poco allettanti, lo stesso sabotaggio può produrre invece per lo più dubbi e timori così che la proposta, almeno per tanti, sia facilmente destinata a cadere nel vuoto .
Naturalmente non esiste una scienza esatta che possa fornire indicazioni chiare su come, quando e dove sia il momento più favorevole per agire in un certo modo. Né successivamente è possibile affidarsi a un qualche modello empirico per sapere precisamente quali siano i suoi frutti: il rischio è quello di giungere a conclusioni troppo semplicistiche, basandosi esclusivamente sugli effetti più immediati e visibili, per cui o un’azione è immediatamente ben accetta da tanti oppure, oltre agli eventuali danni alla controparte, non avrebbe prodotto granché.
Ma gli effetti di ciò che si fa non sempre si manifestano immediatamente, possono anche rimanere nascosti, sedimentarsi, e riapparire più tardi in superficie. Come valutare, ad esempio, se e quanto i sabotaggi precedenti all’estate 2013, pubblicamente denigrati al momento, abbiano poi contribuito alla successiva difesa e ricomparsa di questa pratica in Valsusa?
La mancanza di parametri oggettivi cui affidarsi non vuol dire però che non sia possibile orientarsi in alcun modo di fronte a questo tipo di problemi. Già solo prestare una certa attenzione a riguardo può consentire di affinare una certa capacità intuitiva. E può essere poi di grande aiuto curare la salute del dibattito, cercando di stimolare quante più persone possibili a confrontarsi apertamente sulle varie questioni che emergono nel corso di una lotta.
E del resto il rapporto tra un’azione di sabotaggio e l’andamento complessivo di una lotta dovrebbe essere considerato uno degli aspetti più importanti, almeno per chi ritiene che il sabotaggio non sia il fine ultimo di una lotta, ma solo uno degli strumenti in grado di consentire alla stessa di fare dei passi in avanti dal punto di vista dell’efficacia, della radicalità e della autorganizzazione.
Sono questi gli obiettivi, oltre a ciò per cui o contro cui ci si sta battendo, che una lotta dovrebbe perseguire. Perché il percorso che si fa per raggiungere un certo risultato è quantomeno altrettanto importante dell’esito finale di una lotta.
Consentiteci per una volta un gioco d’immaginazione: quanti No Tav, se oggi potessero scegliere, preferirebbero che la lotta contro il treno veloce si fosse conclusa nel 2004? Magari attraverso un referendum o un ricorso in tribunale, privando così tanti uomini e donne dell’esperienza accumulata durante le battaglie del Seghino e di Venaus, durante i giorni della Libera Repubblica della Maddalena o durante i blocchi dell’autostrada. Quanti sarebbero disposti a rinunciare a tutte quelle situazioni vissute in prima persona che hanno sconvolto la propria quotidianità e modificato profondamente la propria vita e lo sguardo con cui si era abituati a guardare il mondo? Se per lo Stato – come ha dichiarato il procuratore generale Marcello Maddalena nel processo d’Appello contro Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò – in ballo non c’è più la costruzione di una ferrovia ma la facoltà di una democrazia di imporre le proprie decisioni, allo stesso modo diversi No Tav, crediamo, non lottano più «solo» per ostacolare la linea Torino-Lione, ma anche perché si sono accorti che la lotta ha cambiato in meglio la loro vita. Un piacere che non avrebbero provato se invece che lottare avessero delegato ad altri la risoluzione del problema del Tav. Un piacere che perde di intensità quando, nel corso di una lotta, l’autonomia e la partecipazione in prima persona dei singoli vengono soffocate da modi di organizzarsi e decidere il da farsi che privilegiano la delega.
L’eventuale diffondersi di sabotaggi sarebbe quindi importante non solo per i danni arrecati alla controparte, ma soprattutto perché sarebbe un segno dell’agire diretto di tanti. Tanti uomini e donne che potrebbero contribuire attivamente alla lotta, non solo riunendosi tutti insieme per i cortei, i blocchi o le giornate di assedio al cantiere, ma anche agendo autonomamente e scegliendo ognuno con chi, dove e quando andare a gettare uno zoccolo negli ingranaggi dell’Alta Velocità – andare a tirare qualche petardone dentro il cantiere, fare qualche scritta sugli edifici dove alloggiano gli operai o ancora distribuire un volantino, visto che la possibilità di organizzarsi autonomamente riguarda un po’ tutte le iniziative di una lotta.
Abbiamo finora utilizzato il condizionale nel parlare del diffondersi dei sabotaggi perché nonostante ce ne siano stati un certo numero in un breve arco di tempo, specie dopo il maggio 2013, ci sembra eccessivo affermare che questa pratica si sia realmente diffusa. Ci sembra più corretto dire che a diffondersi sia stata la consapevolezza della validità di questa pratica. Emblematico in questo senso il dossier No Tav Watching, contenente l’indirizzario delle ditte che lavorano al cantiere di Chiomonte. Un lavoro di ricerca prezioso che, uscito pochi mesi dopo l’arresto di Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, ha rappresentato un ottima risposta al tentativo della Procura di spaventare il Movimento. Ma, almeno a quanto è dato sapere, non è stato molto utilizzato.
Se si diffondesse questo modo di organizzarsi, scegliendo autonomamente con chi, dove e quando mettere i bastoni tra le ruote al Tav, potrebbero aumentare in molti anche la fiducia e la convinzione nelle proprie capacità. Un processo che potrebbe avere delle conseguenze positive un po’ su tutta la lotta, anche sulle iniziative e discussioni collettive che da questa crescita individuale non potrebbero che essere arricchite.
E sarebbe infatti profondamente sbagliato pensare questa sorta di coordinamento tacito e spontaneo come alternativo, e non piuttosto complementare, agli appuntamenti annunciati e di massa discussi attraverso le assemblee pubbliche.
Una complementarità di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio proprio nel corso della solidarietà sviluppatasi per l’arresto dei sette compagni. Quando, alle iniziative pubblicizzate e partecipate da moltissime persone, si sono intrecciate un gran numero di azioni non annunciate contro alcuni membri del Partito del Tav (ad esempio Partito Democratico, Banca San Paolo e Trenitalia). Azioni che hanno fatto prender corpo, nei fatti, a quelle campagne contro i responsabili politici, imprenditoriali e finanziari della Torino-Lione di cui tanto si era discusso negli anni passati in Valsusa senza però riuscire a farle iniziare. Un modo di organizzarsi che ha inoltre permesso a tanti di dare il proprio contributo alla lotta senza dover raggiungere la Valle.
Se unirsi consente di sommare le forze, dividersi alle volte permette di moltiplicarle.
Questo è uno dei significati dell’azione per cui sono stati arrestati Chiara, Claudio, Mattia, Niccolò e poi Francesco, Graziano e Lucio. Un aspetto che non è stato forse adeguatamente sottolineato nelle tante occasioni in cui negli ultimi tempi si è parlato di quella notte di maggio.
Possiamo dire che la gran parte dei discorsi si sono concentrati sull’aspetto più immediatamente pratico di quell’azione, ovvero l’aver inceppato il normale funzionamento del cantiere, dandone un giudizio molto positivo, come dimostrano le parole d’ordine urlate a squarciagola dopo gli arresti.
Il suo aspetto di metodo, cioè la possibilità di organizzarsi autonomamente, al di fuori delle assemblee popolari e dei coordinamenti dei comitati, invece, è rimasto tutto sommato in ombra e possiamo dire non sia stato digerito fino in fondo.
Un fatto abbastanza comprensibile.
È normale che possano emergere perplessità e preoccupazioni a riguardo in chi è abituato a discutere e decidere esclusivamente in assemblee pubbliche le iniziative da portare avanti – per quanto non si può essere sicuri di sapere tutto quello che accadrà nel corso dell’iniziativa stessa.
In ogni caso l’impossibilità di sapere in anticipo cosa verrà fatto, quando e dove, ciò che insomma rende queste azioni imprevedibili e quindi difficilmente contrastabili dalla controparte, può allo stesso tempo destare preoccupazioni in chi lotta, per l’impossibilità di avere il benché minimo controllo su un’azione che non è detto trovi tutti d’accordo. Una questione che, posta in questi termini, non può avere alcuna soluzione. Questa modalità organizzativa, per funzionare, deve necessariamente escludere tanti compagni di lotta da una serie di informazioni. Ma ci sono diversi modi e diversi momenti con cui gli uomini e le donne che partecipano a una lotta possono influire su un’azione di sabotaggio compiuta da altri, senza naturalmente pensare di poterla determinare. Ad esempio attraverso il dibattito che si sviluppa all’interno di una lotta prima, e attraverso le eventuali critiche o ragionamenti su ciò che è successo poi.
Una possibilità legata evidentemente allo stato di salute delle discussioni e delle strutture organizzative di una lotta. Ecco perché discuterne, avanzando critiche precise quando una certa azione non convince, sarebbe importante.
Esemplare, in negativo, è il modo in cui sono stati affrontati un paio di sabotaggi avvenuti nel dicembre 2014 nei pressi di Bologna e Firenze. A qualche mese di distanza dalla difesa del sabotaggio del 2013, di fronte ad azioni dirette contro le linee ad Alta Velocità, hanno ripreso fiato all’interno del Movimento le ipotesi complottiste. Nella confusione, qualcuno ne ha approfittato per lanciarsi in un attacco a spada tratta del tutto privo di argomentazioni, apparso nella sua forma più chiara sui siti infoaut.org e notav.info in un articolo intitolato I burabacio. L’obiettivo era semplice: inveire contro le azioni di Bologna e Firenze e chi le aveva sostenute, per tentare di scongiurare la possibilità che assieme a una certa pratica si diffondesse anche un certo modo di organizzarsi.
Non sono così emersi quei dubbi che, immaginiamo, molti No Tav nutrissero nei confronti di questi sabotaggi. Ed è stata di fatto ostacolata la possibilità che a partire da questi dubbi si sviluppasse un dibattito. A far tramontare poi definitivamente questa auspicabile ipotesi, soffocando anche i pochi tentativi di riportare il discorso sui binari, sono stati i botta e risposta relativi a I burabacio.
In movimento
Se finora ci siamo concentrati su alcuni aspetti specifici della solidarietà rivolta ai sette compagni arrestati, vorremmo ora soffermarci sugli uomini e le donne che l’hanno portata avanti.
Perché, come accennavamo all’inizio, si è trattato di un contesto molto ampio ed eterogeneo, composto da chi, come i militanti, ha una certa familiarità con carcere e accuse di questo tipo, da altri che, come diversi No Tav, stanno iniziando a doverci fare i conti sempre più spesso negli ultimi tempi, ma anche da chi, come i familiari degli arrestati, è stato invece catapultato in questa situazione per la prima volta.
Sin da subito, dopo i primi arresti, i compagni più vicini agli arrestati hanno cercato di favorire l’incontro tra i familiari pensando che poter discutere e confrontarsi insieme sarebbe stato d’aiuto, sia a livello pratico che emotivo, per affrontare una carcerazione prevedibilmente lunga e un processo con accuse particolarmente pesanti. Un aspetto che nel caso dei primi quattro arrestati è divenuto ancora più importante per il fatto che, fino quasi all’inizio del processo, genitori, fratelli e sorelle sono stati gli unici a poter incontrare Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò. Nel frattempo gravati anche della censura sulla posta che ha reso ancor più complicata la già difficoltosa comunicazione con l’esterno.
Altrettanto importante è sembrato poi cercar di far conoscere ai familiari la lotta No Tav, così che potessero discutere con altri uomini e donne, e non solo con i compagni dei loro cari, delle ragioni della resistenza al treno veloce e del sabotaggio del maggio 2013. Così da rendersi conto in prima persona che non si sarebbero trovati da soli ad affrontare quanto stava accadendo.
Un incontro che, almeno in alcuni familiari, ha favorito anche un processo di messa in discussione di una serie di questioni che fino ad allora per essi non erano all’ordine del giorno, e che non si esaurivano nei problemi specifici che in quel momento stavano vivendo i loro cari in carcere.
E questa tensione critica, insieme all’affetto e al calore manifestato da tanti nei confronti degli arrestati, alcuni familiari l’hanno portata con loro ai colloqui in carcere, sorprendendo favorevolmente i compagni rinchiusi. Un buon esempio a questo riguardo è rappresentato dal testo Alle donne e agli uomini della Val di Susa scritto il giorno dopo «Sapori di Libertà».
Un’iniziativa di cui forse vale la pena parlare.
«Sapori di Libertà» si è svolta in più di un’occasione in alcuni presidi di paesi della Valsusa; lì si sono raccolti e cucinati cibi che chi è andato a fare i colloqui in carcere ha poi portato ai prigionieri. Un modo per consentire ai familiari di andare per la prima volta in Valle in una situazione informale che non li mettesse troppo sotto la luce dei riflettori, e per permettere a tanti No Tav di far sentire a chi si trovava rinchiuso la propria vicinanza, attraverso un pensiero gradito come un formaggio o un salume fatti in casa. Nel suo piccolo, «Sapori di Libertà» è stata anche un’occasione di mostrare cosa sia il carcere nella sua materialità, a partire dal cibo. Non sono stati pochi, infatti, nonostante gli elenchi precisi fatti girare nei giorni precedenti, a portare zucchero, caffè, pasta e altri alimenti vietati, e rimanere sorpresi nello scoprire che alcuni generi erano acquistabili solo allo spaccio interno, spesso a prezzi maggiorati. Oppure che alcuni alimenti potevano invece essere portati a Lucio ma non a Graziano perché ogni carcere è, almeno in parte, differente dagli altri, a causa di imperscrutabili valutazioni della direzione. Aspetti della reclusione che possono essere un buono spunto per discutere e confrontarsi su cosa sia il carcere e cosa voglia dire trovarvisi ristretti, specie all’interno di una lotta con una composizione sociale che non ha la stessa familiarità con la galera che potrebbe avere chi vive in un quartiere proletario. Un sapere che gli oppositori alla Torino-Lione stanno ormai facendo proprio, come sembrano mostrare gli spazzolini e il cambio di biancheria che alcuni No Tav «over 60» hanno portato con sé durante una passeggiata notturna al cantiere per farsi trovare pronti in caso l’iniziativa fosse finita male.
Questo è certamente uno dei pochi casi in cui si è discusso di Alta Sorveglianza, di differenziazione carceraria e di processi in videoconferenza – anche grazie agli scritti di chi era rinchiuso – al di fuori dei ristretti ambiti militanti. E siamo convinti si sarebbe potuto fare di più per far sì che l’arresto dei sette compagni fosse un’occasione per ragionare e confrontarsi non solo su questi aspetti particolari della detenzione ma anche sul carcere più in generale, in modo da allargare notevolmente l’orizzonte al di là delle specifiche detenzioni dei compagni.
A mancare sono state soprattutto le energie e le idee di chi ritiene la lotta contro il carcere una parte importante del proprio percorso, più che l’interesse e l’attenzione degli altri solidali.
Le lettere scritte da dietro le sbarre, non sono state importanti solo per aiutare a comprendere cos’è una sezione di AS2 o un processo in videoconferenza. I sette compagni arrestati erano sconosciuti alla grandissima parte dei No Tav, e molti hanno avuto modo di capire chi fossero e se li conoscessero solo il giorno della prima udienza in Aula Bunker. Prima di questa data sono state le parole scritte nelle loro lettere pubbliche a farli conoscere da tanti solidali e, al di là della solidarietà per il sabotaggio di cui erano accusati che è stata netta e immediata, il calore e la vicinanza che tanti hanno manifestato nei loro confronti sono in buona parte legati a questi testi.
A mo’ di conclusione
La difesa dei compagni arrestati si è da subito intrecciata al tentativo di dare continuità alla lotta contro il treno veloce, senza toni vittimisti che dipingessero gli arrestati come «perseguitati dalla repressione», ma difendendo invece la pratica del sabotaggio, messa alla sbarra insieme ai suoi presunti autori. Per questo, come già detto, le dichiarazioni con cui prima Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò e poi Lucio e Francesco hanno affermato che quella notte di maggio c’erano anche loro non hanno creato imbarazzi o prese di distanza in alcuno, ma generato invece entusiasmo, rafforzando ulteriormente il sentimento di vicinanza nei loro confronti.
L’unica possibilità di contrastare l’operazione della procura torinese ci è sembrata, e ci continua a sembrare, il fare in modo che i discorsi e le iniziative di solidarietà siano indirizzati a rafforzare l’opposizione alla linea Torino-Lione. Perché siamo convinti che, come recita il motto rimasto molte volte solo una lodevole intenzione, «il miglior modo per rispondere alla repressione è quello di continuare le lotte che polizia e magistratura, con processi ed arresti, vorrebbero fermare». Questo perché i processi e gli arresti non sono dei fatti eccezionali, degli incidenti di percorso in cui le lotte alle volte hanno la sfortuna di imbattersi, ma degli elementi che fanno parte delle lotte e che al pari di altri contribuiscono a determinarne l’andamento. E se il lavoro delle forze dell’ordine e dei magistrati – allo stesso modo di recinzioni e filo spinato, campagne terroristiche dei mass-media, promesse di compensazioni – mira a fermare o perlomeno ostacolare la lotta, le nostre energie in queste situazioni devono invece essere dirette a sostenerla e, possibilmente, farle fare dei passi in avanti.
Nel corso di una lotta i nostri desideri e la volontà di cambiare radicalmente questo mondo dovrebbero emergere a partire dagli obiettivi specifici che quel percorso ci pone davanti, attraverso il modo che reputiamo giusto di intervenire, elaborare delle proposte e rapportarci a tutti gli altri compagni di lotta che incontreremo.
La stessa convinzione dovrebbe animarci quando un’operazione della magistratura arresta dei compagni a noi vicini.
La solidarietà espressa dopo l’arresto dei sette compagni è un pezzo dell’opposizione alla realizzazione della linea ad Alta Velocità Torino-Lione. Ed è attraverso questa lente che abbiamo cercato di sottolinearne gli aspetti positivi, i limiti e le potenzialità rimaste inespresse.